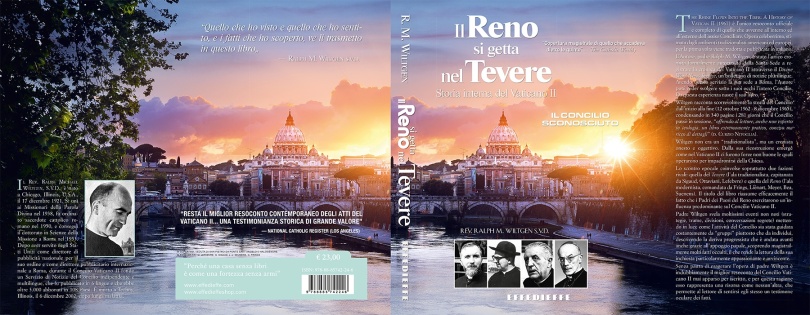Quella del Vaticano II è una storia mai scritta non tanto perché, come spiega l’autore, si scoprono documenti nuovi (vi è anche questo nel libro, ma non è l’elemento preponderante), o perché si svolga un’approfondita disamina teologica dei testi e delle intenzioni dei padri conciliari, quanto perché si ricostruisce l’evento nella sua storia, dalle lontane radici ideali alla sua preparazione, negli eventi degli anni conciliari fino alle conseguenze (gli anni drammatici dell’immediato post-concilio fino al pontificato di papa Francesco).
Una pietra pesante agitò le acque del mondo cattolico italiano nell’inverno del 2010-2011, creando un forte dibattito, nonché un consistente interesse massmediatico.
Già pochi giorni dopo l’uscita nelle librerie del volume sul Concilio ecumenico Vaticano II del professor Roberto de Mattei, persino testate non cattoliche (il Corriere della Sera, il Giornale, Libero, più volte Il Foglio) ne hanno parlato, ma soprattutto nei siti internet cattolici un vasto dibattito si sviluppò ampiamente.
Ciò, in realtà, è più che normale, visto non solo l’importanza dell’argomento in questione (inutile negarlo: la chiave di volta dell’interesse di ogni cattolico – uso a servirsi della propria intelligenza – di questi ultimi 50-60 anni), ma anche del modo in cui viene trattato, del “taglio”, scelto dall’autore, come si evince dallo stesso titolo: Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta (Lindau, Torino 2010, pp. 632, € 38,00).
Una storia mai scritta, non tanto, come specifica l’autore, perché si scoprono documenti nuovi (vi è anche questo nel libro, ma non è l’elemento preponderante), o perché si svolga un’approfondita disamina teologica dei testi e delle intenzioni dei padri conciliari, quanto perché si ricostruisce l’evento nella sua storia, dalle lontane radici ideali alla sua preparazione, negli eventi degli anni conciliari fino alle conseguenze.
A cosa sono dovuti allora tanto interesse e anche tanta polemica su questo studio, visto che si tratta in fondo di una rielaborazione storica? Per comprendere ciò, è necessario tenere presente che il XXI concilio ecumenico della Chiesa Cattolica fu diverso dai venti precedenti, avendo una natura meramente “pastorale”, come vollero dichiaratamente i pontefici che lo aprirono e lo chiusero, Giovanni XXIII e Paolo VI (canonizzati rispettivamente nel 2014 e nel 2018 da papa Francesco); il suo scopo essenziale, cioè, non era quello di condannare eresie, né definire alcuna verità di fede, ma consisteva nel rilancio pastorale della fede cristiana in un mondo profondamente modificatosi.
“Nuova Pentecoste” e “segni dei tempi”
Proprio quest’ultimo elemento però è il perno sul quale girano tutte le problematiche conciliari: per stessa dichiarazione dei padri, ripetuta decine di volte in quegli anni, e migliaia e migliaia nei decenni successivi, la Chiesa doveva ormai “aprirsi al mondo”, guardare in faccia senza timore ai “segni dei tempi” e adattarvisi, fare proprie e attuare concretamente quelle istanze di “nuova teologia”, “nuova ermeneutica”, “nuova liturgia” – inseguite ormai da decenni in vari ambiti teologici (e condannate da san Pio X nel 1907 con l’enciclica Pascendi) – e assumere quell’atteggiamento “nuovo” (fatto di sorrisi inchinanti verso gli odiatori della Chiesa e sovente di sorrisi ironici e sprezzanti verso i difensori della sua civiltà e della sua fede bimillenaria), per non rimanere “chiusa” al mondo ma esserne parte integrante e viva.
Insomma, il Vaticano II doveva essere la chiave di volta di una “nuova Pentecoste” da opporre «ai profeti di sventura» (così bollati da papa Giovanni XXIII nel suo discorso di apertura), i quali ultimi vedevano al contrario senza infingimenti e denunciavano i devastanti mali del mondo contemporaneo, che ben poco di roseo ottimismo potevano suscitare.
In questo senso, chiara fu fin dall’inizio la volontà dei due pontefici di dare un significato innovativo al Concilio, quello appunto della fiduciosa apertura al mondo, in evidente antitesi – occorre dirlo – con tutta la tradizione della Chiesa Cattolica, che ha sempre saputo mantenere ben chiara (in particolare da Gregorio XVI e Pio IX fino a Pio XII), in piena fedeltà all’insegnamento del suo Divino Fondatore e dei grandi Padri e Dottori, la differenza essenziale fra l’amore dovuto al creato e alle creature e l’insensata adesione al mondo. E, in particolare, al nostro mondo, il cosiddetto “mondo moderno”, figlio delle “meraviglie” degli ultimi due secoli, e soprattutto di quelle del XX.
“Aggiornamento” divenne la parola “talismanica”. Scrisse in quei giorni il gesuita progressista John W. O’Malley:
«Nessun concilio prima d’ora ha mai usato l’equivalente di aggiornamento come leitmotiv, come un principio generale più che come rara eccezione, con la conseguenza che per certi aspetti dovrebbe essere la Chiesa a cambiare per incontrare i tempi e non i tempi a cambiare per incontrare la Chiesa» (p. 21).
Questa considerazione si fonda su presupposti teologici di fondamentale importanza (quanto errati se non in certi casi eretici): primo fra tutti, la storicità della Chiesa stessa, che “deve adattarsi ai tempi” (non solo nel senso di “guardare in faccia alla realtà”, come ovvio che sia, ma nel senso di “modificarsi” e “fare propria” questa realtà), quasi si trattasse di un’istituzione politica a scopi umanitari che deve sopravvivere ai vari regimi temporali, e non del Corpo Mistico di Cristo, unico “contenitore” di Verità immutabile e salvezza individuale.
Appare così più chiaro il senso di quel “pastorale”.
L’interpretazione progressista
In tal senso, molti fautori e simpatizzanti del Vaticano II inteso come “innovazione”, come adattamento ai “tempi”, come apertura al mondo – apertura che escludeva ogni condanna, ogni divisione e barriera per accettarlo così come è – hanno messo in risalto, allora come ora, ognuno a suo turno in questi cinquant’anni, il fattore “evento”.
Ciò vuol dire che il Vaticano II stesso non va inteso come qualsiasi concilio precedente, quando la Chiesa “sistemava” definitivamente le sue questioni interne (teologiche, dottrinali, pastorali, disciplinari, ecc.), ma va interpretato alla luce delle sue effettive conseguenze sulla società contemporanea. E, in tal senso, affermano costoro, esso fu anzitutto un “evento” appunto, dirompente, di netta cesura con il passato, di ferma e continua apertura al mondo, con cui occorre “dialogare” (altra parola talismanica conciliare) rifiutando allo stesso tempo qualsiasi spirito missionario di conversione degli infedeli e di coloro che sono a qualsiasi titolo lontani da Gesù Cristo (il dialogo per il dialogo, insomma).
Il “Concilio-evento” è l’interpretazione tipica del progressismo cattolico, che non solo ammira il Concilio Vaticano II, che non solo lo presenta come una sorta di “nuovo punto di partenza” della Chiesa stessa, in contrapposizione netta a tutta la sua esecrata storia precedente, da Pio XII a risalire fino a Costantino e Nicea (la tanto odiata “Chiesa costantiniana”…), e in un del tutto illusorio legame con la “Chiesa primitiva” (altro fantomatico slogan progressista), ma che richiede sempre con maggior insistenza l’indizione di un “Concilio Vaticano III”.
Un nuovo concilio più coraggioso e innovativo, che vada a riempire – stavolta in maniera definitiva – il vuoto lasciato dal pure benemerito e amatissimo Concilio Vaticano II, proprio quello teologico e dottrinale (fine del Primato di Pietro, elezione democratica dei vescovi e del pontefice, sacerdozio femminile, matrimonio libero per il clero, abbattimento di tutte i “muri” dogmatici e teologici che frenano la riunificazione delle Chiese e il dialogo con le altre religioni, apertura piena all’uso degli anticoncezionali – se non dell’aborto – e alle principali istanze bioetiche portate avanti dal mondo laicista e scientista, ecc. ecc.).
Il Vaticano II nel solco della Tradizione
A quest’interpretazione del Vaticano II come rottura con la Tradizione e come evento dirompente in sé, al di là dei suoi aspetti teologici specifici, si contrappose il tentativo – già iniziato sotto il pontificato di Giovanni Paolo II – di Benedetto XVI di presentare l’insegnamento complessivo del Vaticano II nell’ottica di un’«ermeneutica di riforma nella continuità», vale a dire in una visione di continuità teologica con la precedente millenaria tradizione magisteriale della Chiesa stessa.
Ciò, occorre dirlo, è reso possibile anche dal fatto, noto a tutti gli esperti, che i documenti del Concilio sono più o meno tutti scritti in una maniera appositamente studiata per lasciare spazio a più di un’interpretazione. Come scrive il professor de Mattei a p. 13:
«L’esistenza di una pluralità di ermeneutiche attesta per altro una certa ambiguità o ambivalenza di documenti. Quando si deve ricorrere a un criterio ermeneutico esterno al documento per interpretare il documento stesso, è evidente, infatti, che il documento non è in sé sufficientemente chiaro: ha bisogno di essere interpretato, e, in quanto suscettibile di interpretazione, può essere oggetto di critica, storica e teologica».
Il tentativo di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI – porre una barriera definitiva allo slittamento verso l’interpretazione sempre più progressista del Vaticano II e delle sue tesi – è stato quella di far prevalere l’interpretazione più lineare e consona al tradizionale e immutabile magistero della Chiesa.
Tentativo – nobile e necessario – che pare ormai fallito, guardando al programma del pontificato di papa Francesco che si dirigere sempre di più verso quello del desiderato “Concilio Vaticano III” di cui abbiamo accennato poc’anzi.
Questo perché l’ermeneutica della riforma nella continuità non può nascondere – agli occhi dello storico e di tutti i fedeli – prima di tutto l’ambiguità e l’equivocità dei documenti conciliari, in secondo luogo quanto di fatto realmente avvenne durante il Vaticano II, le cause prossime e remote di quanto avvenne, l’opera dei protagonisti e le loro vere intenzioni, le conseguenze che ancora oggi pesano come macigni soprattutto col pontificato di Francesco.
Fonti e affluenti del fiume in piena del progressismo
Ed è proprio questo – la ricostruzione storica – il lavoro condotto con maestria e puntualità da Roberto de Mattei per più di 600 pagine, rese facilmente leggibili – pur nella notevole mole – da uno stile certamente da storico di professione ma pur sempre vivo e coinvolgente, dalla prima pagina all’ultima.
Il prof. de Mattei ha saputo fornire un quadro storico, teologico e ideale delle cause, dei fatti e delle conseguenze, al punto che alla fine della lettura il lettore attento avrà in mente l’intero insieme logico e cronologico di questa immensa e drammatica avventura delle fede che è stata la teologia del XX secolo.
Egli, agganciandosi ai decenni della diffusione delle eresie del modernismo e alla lotta – purtroppo non sufficiente – condotta dal grande papa san Pio X, inizia l’opera fornendo i legami teologici, ideologici e psicologici della parte progressista dei padri conciliari con la prima generazione degli autori e dei “maestri” del modernismo internazionale (Alfred Loisy, George Tyrrell, Maurice Blondel e l’italiano Ernesto Buonaiuti), coloro che hanno impostato mentalmente e, a volte già concretamente, le ideologie criptomoderniste che poi avranno influenza più o meno determinante sull’andamento del Vaticano II.
Spiega cosa furono e quale influenza ebbero la riscoperta del metodo storico-critico («con cui Erasmo tre secoli prima aveva spianato la strada alla Rivoluzione protestante», p. 41) per l’interpretazione delle fonti, il movimento biblico, il movimento liturgico (l’inizio della democratizzazione della liturgia), il movimento filosofico-teologico con la sua apertura all’immanentismo moderno e contemporaneo, il movimento ecumenico, allora ai suoi primi passi.
Basilare attenzione poi l’autore riserva agli anni del pontificato di Pio XII, quando a formarsi e a entrare in azione è la seconda generazione di modernisti e progressisti, coloro che avranno il peso decisivo sul Vaticano II – ovvero i membri della nouvelle theologie (tra cui ricordiamo il filosofo Jacques Maritain, i teologi domenicani Yves Congar, Dominique Chenu, Edward Schillebeeckx, e i teologici gesuiti Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Jean Danielou, ma soprattutto Karl Rahner) – maestri e guide dei maggiori protagonisti progressisti del XXI concilio ecumenico.
Il grande scontro fra due visioni della fede e del mondo
Finita la grande premessa, il prof. de Mattei entra nel cuore della battaglia conciliare, spiegando chiaramente e senza false remore l’azione dei due grandi “partiti” – se così si possono definire – che si affrontarono nel Concilio, mettendo continuamente in evidenza come i progressisti, minoritari soprattutto agli inizi, seppero fin da subito prendere l’iniziativa per dirigere gli eventi e influenzare lo stesso Giovanni XXIII, il quale, certo senza grande rammarico, permise loro di divenire i controllori dei “vota”, degli “Schemata”, delle sessioni, della preparazione di ogni sessione, insomma, dell’intero svolgersi del dibattito conciliare.
I padri fedeli alla Tradizione solo a partire dal 1964 riuscirono a organizzarsi, ma – sempre privi di quell’arroganza dei progressisti ora ancor più sostenuta dal nuovo pontefice, Paolo VI – poco poterono fare per frenare i grandi mutamenti in corso.
Il prof. de Mattei riporta molte testimonianze del dolore e dello sconcerto dei padri fedeli alla Tradizione per quanto stava accadendo, e ricostruisce la loro tarda reazione che fu tarda, sì, ma comunque provvidenziale.
Dalla lettura complessiva dell’opera, traspare la piena volontà dei padri progressisti (il cui cuore battente erano alcuni decisivi esponenti del clero brasiliano, francese, tedesco, belga, olandese e anche italiano) – i veri protagonisti del Concilio – di intervenire su tutte le più grandi problematiche teologiche e politiche del tempo, e di intervenire in maniera sempre più innovativa e spesso con spirito di rottura e divisione con la Tradizione della Chiesa: tutto, secondo costoro, andava ridiscusso e “aggiornato”. E se qualcosa venne ribadito nella linea tradizionale, fu solo per la resistenza dei padri fedeli alla Tradizione, che qualche volta riuscì a prevalere.
Il prof. de Mattei dimostra bene, da esperto storico, dati alla mano, come in questo colossale ed epocale “match” giocatosi all’interno di tutta la Chiesa riunita in quel concilio ecumenico, una minoranza attivissima e caparbia ha sempre attaccato per prima e spesso segnato i suoi goal, mentre la grande maggioranza silenziosa, quella dei padri conservatori, confusa, solo in ritardo è riuscita a contrattaccare e frenare alcune fra le pretese più sovversive dei primi.
Tutto, come detto, fu campo di scontro: nuova esegesi biblica, la critica alle fonti della Rivelazione, l’ecumenismo irenistico come fine supremo dei “tempi nuovi”, la riforma liturgica, la creazione delle conferenze episcopali così come le conosciamo oggi, la riforma della Curia romana, la visione minimalista sulla questione mariana (fu bloccata la volontà di molti padri della definizione del dogma della Mediazione universale della Beata Vergine Maria), la guerra al Primato di Pietro, l’opposizione al Santo Uffizio e di contro l’istituzione del principio di collegialità, la questione del rapporto con gli ebrei e con le altre religioni, il principio della libertà religiosa, il mancato riferimento alla dannazione eterna e, soprattutto, la mancata condanna del più grande dei mali presenti in quegli anni, il comunismo (proprio da parte di quel Concilio che si dichiarava “pastorale” e che voleva leggere i “segni dei tempi”) e l’inizio dell’Ostpolitik vaticana, passando per la critica alla Casti Connubi che presupponeva aperture in campo morale (lo stesso Paolo VI sarà poi costretto a porre un freno essenziale alla deriva morale con l’enciclica Humanae Vitae), la modernizzazione della vita religiosa, fino ad arrivare alla deriva post-conciliare (il famigerato catechismo olandese, la teologia della liberazione, l’ecumenismo sfrenato, la spaventosa decadenza morale di parte del clero, l’odio verso la nostra civiltà e tradizione, ecc. ecc.), nonché al Novus Ordo Missae e alla democratizzazione del rito cattolico.
Deriva talmente tragica che spinse lo stesso Paolo VI a parlare di «autodemolizione» della Chiesa e di «fumo di Satana» entrato nelle fessure della Chiesa stessa (superfluo ricordare i devastanti dati statistici sul crollo delle vocazioni religiose, sullo svuotamento delle chiese, sulla perdita delle fede, negli ultimi quaranta anni, per non parlare della decadenza generale di costumi del mondo cattolico).
Un’immensa guerra interna, dove i progressisti, spesso (almeno agli inizi) avvantaggiati dai due pontefici ma soprattutto sostenuti dai mass-media del tempo, provarono il grande colpo sognato da decenni dai più noti teologi modernisti: quello di cambiare la Chiesa, di toccare lo stesso immutabile e sacrosanto Depositum Fidei. E i risultati, oggi, sono davanti agli occhi di tutti…
False “pentecosti”
Insomma, si tratta di un’opera di ricostruzione di una delle pagine più importanti e decisive della storia della Chiesa e dell’umanità intera, di cui tutti noi oggi viventi siamo figli diretti. In piena unione e filiale devozione all’allora pontefice regnante, Benedetto XVI, – come egli stesso dichiara – l’autore offre a ogni cattolico un materiale prezioso e indispensabile per la comprensione di quella crisi della Chiesa che da più di quarant’anni è dinanzi ai nostri occhi e che oggi – col pontificato di papa Francesco – ha raggiunto vortici devastanti e impensabili.
Nessuna “primavera” e nessuna “nuova Pentecoste”, insomma (occorre dirlo, ormai, senza inutili infingimenti). Anzi, il disastro. Non avevano proprio tutti i torti i tanto esecrati profeti di sventura…
Questo testo di Massimo Viglione è stato tratto dal periodico Radici Cristiane.
RadioRomaLibera.org
 Monsignor Luigi Negri, che fu allievo di Romano Amerio, dice nell’introduzione:
Monsignor Luigi Negri, che fu allievo di Romano Amerio, dice nell’introduzione: Occupandosi della crisi nella Chiesa, Amerio scrive:
Occupandosi della crisi nella Chiesa, Amerio scrive: